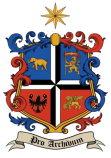I nostri standard
Standard internazionali
Il panorama degli standard archivistici internazionali o comunque connessi con lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi documentari, rilasciati da organismi internazionali deputati alla loro elaborazione e al loro aggiornamento o affermatisi come standard di fatto a causa della loro diffusione e il loro ampio uso, è quanto mai articolato e vario.
Nello sviluppo degli standard relativi al Sistema Archivistico Nazionale, si è fatto riferimento ad alcuni di essi, in particolare a quelli descrittivi elaborati sotto gli auspici del Consiglio Internazionale degli Archivi, nonché agli standard per la codifica in XML di strumenti di ricerca archivistici, di descrizioni di soggetti produttori e di metadati descrittivi elaborati su iniziativa della Society of American Archivists e della Library of Congress di Washington.
• ISAD (G)
• ISAAR (CPF)
• ISDIAH
• EAD
• EAC-CPF
• METS
ISAD (G)
Lo standard internazionale di descrizione archivistica è stato elaborato tra il 1988 e il 1993 dalla Commissione ad hoc per gli standard di descrizione del Consiglio internazionale degli archivi (ICA/DDS), Commissione diventata Comitato permanente al Congresso internazionale degli archivi di Pechino del 1996.
Tali regole sono state sottoposte a revisione nel quinquennio successivo (fino al settembre 1998) e sulla base delle proposte inviate da 25 paesi (tra cui l’Italia) è stata elaborata la seconda edizione delle regole, approvata nel settembre 1999 a Stoccolma, e resa pubblica durante il Congresso ICA di Siviglia nel settembre 2000: International Council on Archives / Conseil international des archives, ISAD (G): General International Standard Archival Description, Second Edition, Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, Ottawa, 2000.
ISAAR (CPF)
La prima edizione dello standard internazionale per i record d’autorità archivistici di enti, persone e famiglie (descrizione dei soggetti produttori in file d’autorità separati dalle descrizioni di entità archivistiche ma ad esse connessa), è stata elaborata tra il 1993 e il 1995 dalla Commissione ad hoc per gli standard descrittivi del Consiglio internazionale degli archivi (ICA/DDS), Commissione diventata Comitato permanente al Congresso internazionale degli archivi di Pechino del 1996.
Tali regole, che si propongono di gestire le informazioni relative ai soggetti produttori, pubblicate nel 1996, sono state sottoposte a revisione nel quadriennio 2000-2004 e sulla base delle proposte è stata elaborata la seconda edizione, discussa e approvata a Canberra (Australia) nell’ottobre 2003 e successivamente pubblicata e presentata al Congresso ICA di Vienna nel 2004: International Council on Archives / Conseil international des archives, ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, Persons and Families, Second Edition, Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Canberra, Australia, 27-30 October 2003.
ISDIAH
Una prima bozza dello standard internazionale per la descrizione degli istituti conservatori di archivi è stata elaborata da un gruppo di lavoro del Comitato per le buone pratiche e gli standard del Consiglio Internazionale degli Archivi (ICA/CBPS) a Milano nel gennaio 2006 e discussa, emendata e integrata a Madrid nel maggio 2007.
Fra il luglio e il novembre 2007 la bozza è stata fatta circolare per sollecitare i commenti della comunità archivistica internazionale. Nella successiva riunione di Londra del 10-11 marzo 2008, il gruppo di lavoro ha preso in esame i commenti pervenuti ed ha emendato la bozza, laddove opportuno, redigendo la versione definitiva della standard, successivamente approvata dalla Commissione di programma del Consiglio Internazionale degli Archivi (ICA/PCOM) e sottoposta al Consiglio esecutivo del CIA per la sua formale adozione.
La versione definitiva dello standard è stata presentata al Congresso ICA di Kuala Lumpur nel 2008: International Council on Archives / Conseil international des archives, ISDIAH. International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, First edition, Developed by the Committee on Best Practices and Standards, London, United Kingdom, 10-11 March 2008.
EAD
L’origine di EAD – Encoded Archival Description risale al Berkeley Finding Aids Project (BFAP), avviato nel 1993, presso la Berkeley University in California, con l’intento di sviluppare uno standard non proprietario per la codifica in formato digitale di strumenti di ricerca quali inventari, elenchi sommari, indici facendo ricorso allo Standard Generalised Mark-up Language (SGML). L’adozione di SGML come linguaggio di codifica portò all’elaborazione di una prima DTD sperimentale, che, dopo il coinvolgimento nel progetto di altre istituzioni di conservazione e di ricerca, compresa la Library of Congress di Washington, e l’interesse manifestato dalla comunità archivistica statunitense e dalla Society of American Archivists, fu ulteriormente perfezionata ed assunse, nell’estate del 1995, il nome di Encoded Archival Description.
La versione 1.0 di EAD è stata rilasciata nel 1998, accompagnata dalla pubblicazione della Tag library e delle Application guidelines sul sito ufficiale del progetto, ospitato all’interno di quello della Library of Congress, che del mantenimento di EAD era, nel frattempo, diventata l’agenzia responsabile.
EAD si è proposto come uno strumento per la conversione e la pubblicazione in formato elettronico di strumenti di ricerca archivistici prodotti originariamente su supporto cartaceo e la loro pubblicazione in formato elettronico nonché per l’elaborazione e lo scambio di descrizioni archivistiche in formato nativamente digitale. L’adozione di standard e tecnologie come XML che consentono la conservazione e la comunicazione dei dati, indipendentemente da specifiche piattaforme hardware e software, mira a garantire la persistenza della struttura e del contenuto delle descrizioni, e la loro accessibilità e validità nel tempo.
Nel 2002, dopo una fase di revisione durata molti mesi e che ha visto il coinvolgimento di archivisti di altri paesi (Australia, Canada, Francia e Gran Bretagna) fu rilasciata una nuova versione della DTD (EAD 2002), che non ha introdotto radicali modifiche rispetto alle versione 1.0, ma ha provveduto soprattutto ad adeguare taluni suoi elementi alla nuova edizione del General International Standard Archival Description, ISAD (G), pubblicata nel 2000. Frattanto è stata realizzata la conversione della DTD in XML, linguaggio di marcatura con il quale essa era già sostanzialmente compatibile fin dalla versione 1.0 del 1998.
Nel 2010 è stata avviata un ulteriore fase di revisione che ha portato al rilascio nell’agosto 2015 di una nuova versione dello standard denominata EAD3, che ha introdotto mutamenti significativi sia nella struttura del tracciato XML che negli elementi descrittivi.
EAC-CPF
EAC-CPF – Encoded Archival Context-Corporate Bodies, Persons and Families intende costituire uno standard per la codifica in XML e l’interscambio di record di autorità basati sull’International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, Persons and Families – ISAAR (CPF).
Esso trae origine da un gruppo di lavoro internazionale riunitosi per la prima volta a Toronto nel marzo 2001, la cui attività produsse, nel 2004, una versione beta dello standard che fu sperimentato in vari progetti europei e americani. Nel 2007 l’iniziativa fu ripresa sotto l’egida della Society of American Archivists, che costituì un nuovo gruppo di lavoro, ampiamente rappresentativo del mondo archivistico europeo e statunitense. Nel meeting tenutosi a Bologna nel maggio 2008, grazie al supporto della Gladys Krieble Delmas Foundation, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, dell’Archivio di Stato di Bologna, il gruppo di lavoro stabilì le linee fondamentali della struttura e degli elementi dello standard. Il lavoro, proseguito per posta elettronica e conference call, portò, nell’agosto 2009, alla redazione della bozza definitiva della nuova versione dello standard, sulla quale la comunità archivistica internazionale fu chiamata ad esprimere osservazioni e commenti. Il tracciato definitivo dello standard, il relativo schema e la tag library sono stati rilasciati nel marzo 2010.
La struttura dello standard è basata su due elementi contenitori obbligatori, e o in alternativa . L’elemento raccoglie i dati relativi alla produzione e all’aggiornamento del record EAC-CPF; l’elemento contiene informazioni sull’entità descritta e le relazioni con le entità e le risorse informative connesse. L’elemento è utilizzato quando l’entità presenta molteplici identità, che devono essere descritte singolarmente.
METS
Il formato METS – Metadata Encoding and Transmission Standard definisce un meccanismo flessibile per la codifica di metadati descrittivi, amministrativi e strutturali per gli oggetti che fanno parte di archivi o biblioteche digitali, e per documentare le relazioni complesse tra le varie forme di metadati. Esso può, inoltre, fornire un utile standard per lo scambio tra depositi di oggetti appartenenti alla biblioteca digitale. Infine, lo schema METS offre la capacità di associare un oggetto digitale a comportamenti o servizi. È basato sul linguaggio XML ed è manutenuto dal Network Development e MARC Standards Office della Library of Congress.
Un documento METS è costituito da sette sezioni principali:
– Intestazione METS: contiene i metadati che descrivono il documento METS, includendo alcune informazioni quali il responsabile, la data di elaborazione, lo status etc.
– Metadati descrittivi: contiene descrizioni, anche multiple, degli oggetti digitali espresse con metadati inclusi nel documento METS secondo formati standard oppure un link a record descrittivi esterni presenti in cataloghi bibliografici o banche dati archivistiche.
– Metadati amministrativi: contiene sia informazioni sugli oggetti digitali, che sul copyright, che sulle relazioni fra gli oggetti della biblioteca digitale (ad es. le relazioni dei file master e di derivazione e le informazioni riguardo la migrazione e la trasformazione). Allo stesso modo dei metadati descrittivi, i metadati amministrativi potrebbero essere sia esterni al documento METS che codificati internamente.
– Sezione file: contiene la lista dei file degli oggetti digitali descritti nel documento METS.
– Mappa strutturale: indica la struttura gerarchica a cui appartiene l’oggetto della biblioteca digitale, e collega gli elementi di quella struttura ai file di contenuto ed ai metadati appartenenti ad ogni elemento.
– Link strutturali: permette di memorizzare l’esistenza di hyperlinks tra i nodi definiti nella Mappa strutturale.
– Comportamento: indica i comportamenti dell’oggetto digitale.
https://www.icar.beniculturali.it/standard/standard-internazionali